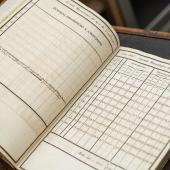L'utilizzo politico della storia e dell'archeologia
Il dualismo narrativo è un antico vizio capitale della storiografia e si ripercuote nelle opinioni e nel dialogo politico. Tecnicamente il bias teleologico è la tendenza a piegare il passato entro i confini di un arco narrativo necessariamente lineare. Così il racconto storico diventa una freccia direttamente scagliata verso un presente di natura politica, secondo un meccanismo che non descrive, non decodifica, ma essenzialmente giustifica qualcosa.
Nell’archeologia biblica del secolo scorso emerge una narrazione che mira a ricostruire la storia del popolo ebraico in Palestina come una sorta di continuum di predestinazione, culminante nell’epifania dello Stato di Israele del 1948. Il risultato è un taglio selettivo della memoria, che privilegia le tracce di persistenza e nasconde le altre presenze, le fratture, le dispersioni. In un’altra prospettiva.
Il 1948 segna la prima simmetria irrisolta: la Nakba, l’esodo degli arabo-palestinesi dalle terre in cui vivevano. Dopo il 1967, l’archeologia è diventata, anche per una parte dei palestinesi, un luogo di conflitto simbolico e nuove asimmetrie. Nella legittima ricerca di valorizzare la presenza araba e islamica nella regione, spesso sono stati enfatizzati gli aspetti dell’origine e della permanenza ininterrotta fin dalla più remota protostoria. Si è così sviluppato un contro-racconto altrettanto teleologico, come se il radicamento territoriale di un popolo dovesse necessariamente passare per una sorta di immobilismo millenario.
Se la legittimazione nazionale riduce la storia a due sole traiettorie parallele, che ovviamente si escludono, si finisce per oscurare tutto ciò che ha reso il Medio Oriente un laboratorio perenne di contaminazioni, incroci, fratture e ricomposizioni. La scrittura del mito dell’origine non può ammettere il disordine e la casualità del reale. Quali soluzioni? Chi opera nel mondo dei saperi può impegnarsi in una decostruzione dei pregiudizi e far emergere tutta l’artificialità dell’utilizzo politico della storia. Se le comunità accademiche possono produrre impatto sociale, devono agire sulla percezione stessa delle zone di frontiera, chiarendo chi definiscono e chi lasciano drammaticamente fuori. Vuol dire lavorare eticamente dentro la società per far comprendere e accettare l’alterità e per annullare la costruzione artificiale delle diseguaglianze.